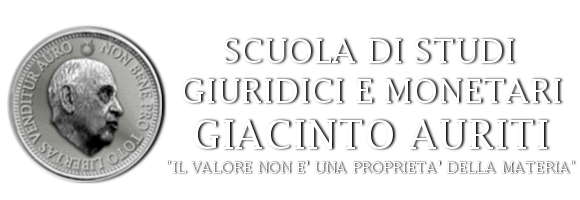Reddito Cittadinanza e prospettiva auritiana: precisazioni

Rispondiamo ad un articolo di Andrea Cavalleri pubblicato sul sito di Maurizio Blondet dal titolo
" Reddito di Cittadinanza: l'errore di Auriti "
________________________________________________________________________________________
L’amico Andrea Cavalleri, ispirato da un precedente articolo di Maurizio Blondet, ha proposto una interessante riflessione sul “reddito di cittadinanza” e le sue problematicità.
Argomentando in merito Cavalleri, senza alcuna intenzione polemica (di questo sono certo), ha tirato in ballo la teoria monetaria di Giacinto Auriti in modo, a dire il vero, alquanto fuori contesto dal momento che Auriti non ha mai proposto, in forma diretta, alcun reddito di cittadinanza ma è solo intervenuto, nel dibattito in questione, osservando che la teoria della proprietà popolare della moneta, se applicata, avrebbe potuto realizzare una forma di redistribuzione sociale del reddito monetario che si avvicina a quella indicata, ma su altre basi, dai sostenitori del reddito di cittadinanza.
Andrea Cavalleri nel suo articolo ha fatto riferimento alle idee monetarie di Silvio Gesell, il geniale ministro della repubblica socialista bavarese dell’immediato primo dopoguerra. Le idee geselliane, di matrice proudhoniana, non a caso furono, per certi aspetti, riprese, negli ‘20 e ‘30 del secolo scorso, dal maggiore C.H. Douglas con la sua proposta monetaria fondata sul concetto di “credito sociale”.
La proposta auritiana a proposito del reddito di cittadinanza tuttavia, a parere dello scrivente, si avvicina, e non si pone in antagonismo, all’idea geselliana della moneta quale strumento di redistribuzione del prodotto del lavoro sociale.
Il miglior servizio che si possa fare al pensiero economico dominante, mainstream, è quello di opporre l’una all’altra le teorie monetarie eterodosse in nome di inutili gelosie di scuola. Infatti le teorie eterodosse colgono, tutte, i guasti della concezione materialista della moneta, la moneta-merce del filone smithiano-hayekiano-misesiano-friedmaniano, e tutte propongono diverse concezioni che hanno il loro comune denominatore nel superamento del concetto della moneta come una tra le tante merci scelte per essere usata quale unità di scambio dei beni. Concezione, questa merceologica, risalente ai tempi della moneta oro ma, a ben ragionare, infondata anche a quei tempi. Qui però non possiamo affrontare questo tema dovendo, per ragioni di spazio, restare sul piano degli argomenti proposti da Maurizio Blondet, circa l’avanzare sull’onda grillina della proposta del reddito di cittadinanza, e da Andrea Cavalleri, circa le connessioni tra queste proposte e la teoria auritiana della moneta.
Innanzitutto è necessario chiarirsi sul concetto di reddito di cittadinanza perché spesso si fanno passare per tale proposte che tali non sono. Anche i grillini parlano di reddito di cittadinanza ma in realtà, a dimostrazione di quanta sia precaria la loro consistenza culturale, fanno riferimento piuttosto ad una forma di reddito minimo garantito, che è cosa diversa.
Infatti, il “reddito di cittadinanza” – si vedano in proposito gli scritti, facilmente reperibili sul web, di Andrea Fumagalli, docente di economia all’Università di Pavia – è un reddito universale riconosciuto a ciascun cittadino indipendentemente dalla sua ricchezza, quindi è riconosciuto anche ai ricchi, indipendentemente dal fatto che il cittadino lavori o meno ed indipendentemente dall’obbligo di seguire corsi di formazione professionale per il reinserimento lavorativo. Il reddito di cittadinanza ha, nelle intenzioni dei suoi sostenitori, un carattere universalista ed incondizionato.
Il citato Fumagalli, nei suoi scritti, elabora anche puntuali calcoli tesi a dimostrare che il prelievo fiscale, opportunamente riformato in modo da impostarlo a discapito della rendita finanziaria, ossia tassandola, ed in base ad una accurata spending rewiew che elimini ogni altra attuale forma di assistenza, che con l’introduzione del reddito di cittadinanza sarebbe inutile, nonché tagliando spese inopportune, ad iniziare da quelli militari (qui si sconta il tipico pacifismo anarchico radicale), sarebbe in grado di garantire le risorse per applicare la redistribuzione sociale del gettito stesso, assicurando un reddito mensile pro capite aggirantesi tra gli 800 ed i 1.200 euro.
L’idea base della proposta del reddito di cittadinanza sta, in particolare, in una istanza tipicamente libertaria che è quella di liberare l’uomo dall’obbligo di lavorare, soprattutto nella prospettiva futura della completa automazione della produzione che necessiterà di procurare ai consumatori il reddito necessario allo sbocco della produzione automatizzata e – soprattutto, si badi – socializzata, dato che in effetti l’automazione sta riportando alla ribalta, a dimostrazione di come il capitalismo liberista si scavi da solo la fossa sotto i piedi, utopie comuniste intese all’eliminazione della proprietà e dello Stato.
Nell’idea di liberare l’uomo dal lavoro, o perlomeno di metterlo nelle condizioni di accettare liberamente, e non per bisogno, un lavoro, riecheggia una verità biblica che, però, i sostenitori del reddito di cittadinanza misconoscono non tenendo conto del passaggio dallo stato adamitico a quello post-adamitico dell’umanità e pretendendo di restituire a questa quella originaria e perduta condizione indipendentemente dal Sacrificio di Cristo sulla Croce. La Rivelazione ci parla di un uomo che anche in origine era chiamato a lavorare – “coltivare l’Eden” – ma per il quale il lavoro non era pena ma, nell’Amore di Dio al quale egli era unito ontologicamente, gioia. Il lavoro diventa pena e condanna, fatica e sudore, solo a seguito del peccato d’orgoglio ossia della pretesa umana di autodeificarsi, di imporsi ontologicamente in termini autoreferenziali che è come dire di non riconoscere più la propria radice esistenziale in Dio. Non a caso in molte lingue il termine per indicare il lavoro-pena è lo stesso di quello che indica la fatica ed il dolore, compreso quello del parto, ossia “travaglio”. Nonostante il peccato d’origine, che ha solo ferito e non del tutto corrotto la struttura ontologica umana, il lavoro-gioia è ancora parzialmente conservato in quelle attività creative dell’uomo come l’artigianato e l’arte che sono caratterizzate da un’alta realizzazione spirituale che rende non penosa la fatica umana. Ora, però, è evidente che qualsiasi proposta intesa a restituire all’uomo il lavoro-gioia, senza alcun riferimento alla necessaria Redenzione spirituale dell’uomo stesso, altro non è che una scimmiottatura luciferina della Salvezza.
Il reddito di cittadinanza è, a un punto di vista storico, una idea post-fordista, una proposta di welfare post-statuale e post-keynesiano, molto confacente alla società liquida e nichilista fondata su un acceso individualismo anche, appunto, nella sua forma libertaria. Ecco perché tale idea è diventata il cavallo di battaglia della sinistra post-operaista, fuoriuscita dal ’68 anarco-libertario, molto vicina, per certi versi, all’anarco-liberismo americano.
Dunque non meraviglia il fatto che, come ha fatto osservare Maurizio Blondet, il reddito di cittadinanza era visto favorevolmente anche dal padre del neoliberismo monetarista, Milton Friedman, quale strumento per assicurare il reddito necessario a sostenere la domanda per assorbire l’offerta. Milton Friedman vedeva con favore il reddito di cittadinanza proprio perché esso si palesa come un superamento della presenza attiva, keynesiana, dello Stato nel mercato.
Questo spiega perché, di recente, sono state avanzate ipotesi, applaudite anche dalla sinistra, di “quantitative easing popolare” ossia di redistribuzione della liquidità pompata dalla Banche Centrali non più attraverso il sistema bancario, che non sempre assicura che detta liquidità arrivi effettivamente alle famiglie, ma direttamente ai cittadini che in tal modo, spendendola, riattiverebbero i consumi e il mercato ingessato dalla deflazione. Dietro queste ipotesi, che provengono dal mainstream economico, si cela, in realtà, il fronte di resistenza liberista ad ogni possibile ritorno del keynesismo e di una presenza attiva, mediante il deficit spending assicurato da Banche centrali non indipendenti dai governi, dello Stato in economia.
La pericolosità di queste proposte, come ben osservato da Blondet, sta nella concezione elargitrice della redistribuzione che finirebbe per fare dei cittadini i sudditi del già vasto potere central-bancario. Ora, però, proprio la prospettiva auritiana, sulla quale torneremo, sarebbe un impedimento a tale pericolo dato che, in quella prospettiva, nessuna elargizione benevola e strumentale sarebbe ammessa ma l’attribuzione, o accreditamento, della moneta sarebbe un diritto soggettivo, personale, di ciascun cittadino all’atto dell’emissione monetaria, e non solo in occasioni di crisi economiche.
Come dicevamo, spesso si fanno passare per reddito di cittadinanza proposte similari che in effetti hanno però diverse basi concettuali e diversa funzionalità. Si confonde spesso il reddito di cittadinanza con il “reddito minimo garantito”, che, raccomandato da alcune pronunce del Parlamento Europeo e della stessa Commissione, già esiste in tutti i Paesi dell’UE ad eccetto dell’Italia e della Grecia.
Il reddito minimo garantito, a differenza del reddito di cittadinanza, non ha carattere universalista ed incondizionato ma è un reddito attribuito soltanto ai disoccupati ed ai poveri ed è legato all’obbligo della formazione permanente e continua con l’obiettivo del reinserimento occupazione di colui che ne beneficia. Esso è spesso accompagnato da altri benefici finalizzati a sostenere il costo dell’affitto di casa e quello del mantenimento dei figli commisurato alla concreta situazione familiare (quindi diversificato a seconda che si tratta di famiglia con entrambi i genitori disoccupati o con famiglia in cui un genitore lavora o ancora che si tratta di famiglia monoparentale con il genitore che non lavora o il cui reddito da lavoro sia insufficiente).
Il reddito minimo garantito è una proposta di matrice ordoliberale e non a caso è lo strumento di welfare tipico della Germania attuale la cui filosofia sociale è appunto ispirata alla scuola ordoliberale di Friburgo. Quindi quando i grillini avanzano la loro proposta di “reddito di cittadinanza” condizionato alla formazione professionale ed all’obbligo di accettare una proposta di lavoro stanno perorando una forma di reddito minimo garantito, dunque una antica idea liberale, e non di reddito di cittadinanza. Qualcuno dovrà pur dirlo a Beppe Grillo, a Di Maio, alla Raggi e compagnia bella, che amano presentarsi, agli allocchi che danno loro il voto, come il nuovo che avanza.
Il reddito minimo garantito è una proposta probabilmente più realista del reddito di cittadinanza, e forse anche meno costosa, e non a caso, come detto, ha già trovato ampia applicazione nei Paesi dell’UE. Tuttavia è anche una proposta chiaramente funzionale al capitalismo liberista in quanto si preoccupa, scaricandone i costi sullo Stato, del reinserimento occupazionale dei disoccupati che l’irresponsabilità liberista del capitale – nonostante le tante chiacchere moraliste ed ordoliberali in tema di “responsabilità solidale dell’impresa” a copertura della triste realtà del cinismo più radicale – abbandona sulla strada e che lo Stato non può “licenziare” dalla loro condizione di cittadini dovendosene pertanto in un modo o nell’altro farsi carico.
Infatti, il rovescio della medaglia del reddito minimo garantito è quello di ampliare l’irresponsabilità sociale del capitale, che così può tranquillamente delocalizzare tanto ai lavoratori licenziati ci pensa lo Stato. Al fine di rendere il reddito minimo garantito meno funzionale all’irresponsabilità liberista del capitalismo terminale si dovrebbe affiancarlo con una serie di penalità per il capitale che abbandona i lavoratori come quella di porre salati dazi doganali alla produzione delocalizzata che pretende poi di rientrare sul mercato interno oppure quella di far contribuire il capitale in una quota a tal punto rilevante e tale da scoraggiare le delocalizzazioni ai costi del sussidio garantito per i disoccupati.
Veniamo ora alla prospettiva auritiana in tema di reddito di cittadinanza.
Giacinto Auriti ha iniziato a studiare le questioni monetarie e bancarie dagli anni ’60 ossia in un periodo nel quale, ancora egemone il welfare statualista e keynesiano, di reddito di cittadinanza non si parlava affatto. Ed infatti il nostro ne ha iniziato a trattare solo negli ultimi anni del secolo scorso, poco prima della morte, e solo approfittando del fatto che l’idea in questione era ormai all’ordine del giorno del pubblico dibattito. In tale dibattito egli intervenne per dire che la sua teoria della proprietà popolare della moneta avrebbe potuto facilitare l’applicazione delle proposte inerenti il reddito garantito, di cittadinanza o solo minimo che fosse.
Dunque attribuire ad Auriti una qualunque paternità dell’idea del reddito di cittadinanza non è esatto.
Quello che il nostro giurista della moneta faceva osservare ai sostenitori del reddito di cittadinanza era semplicemente che l’eventuale messa in opera della proprietà popolare della moneta, con il conseguente accreditamento al cittadino all’atto dell’emissione da parte dello Stato o della Banca Centrale della moneta medesima, diventava ipso facto il modo più realista di avvicinarsi alla redistribuzione del reddito direttamente ai cittadini. Realista perché tale redistribuzione non sarebbe avvenuta ad ogni esercizio finanziario dello Stato, come si pretende, ma solo ad ogni nuova emissione di moneta, quindi non sempre ma solo periodicamente. L’applicazione di una forma di reddito garantito nella prospettiva auritiana taciterebbe le critiche di coloro che additano il reddito di cittadinanza come un mero espediente per mantenere a carico di chi lavora la parte inattiva della popolazione e consentire ai disoccupati di non impegnarsi nella formazione professionale per la ricerca di una occupazione.
L’amico Andrea Cavalleri accenna nel suo articolo anche una critica al concetto di “valore indotto” che Auriti ha posto alla base della sua teoria. Però Cavalleri non sembra aver ben compreso il significato autentico del “valore indotto” auritiano che non è altro che un nome diverso del concetto di “potere d’acquisto”.
Il “valore indotto” è la risposta alla domanda “per quale motivo un pezzo di carta senza alcun valore intrinseco possiede la capacità di acquistare beni di valore”?
Nell’epoca, molto antica, dell’oro e degli altri metalli preziosi tagliati sui banchi dei mercanti e pesati per commisurare il valore dei beni che si scambiavano, il metallo era uno tra i tanti beni usati per l’intermediazione commerciale. Da qui la svista, che denota una concezione retrò ed attardata, della Scuola Austriaca (von Hayek e von Mises sulla scia di Adam Smith) che continua a ritenere la moneta una merce ed invoca il non abbandono del gold standard, capace di garantire la stabilità dei prezzi: assunto nient’affatto veritiero giacché anche l’oro in quanto bene è suscettibile, per molteplici ragioni, di variazione di prezzo.
Per la fase storica nella quale si tagliavano e si pesavano i metalli, per misurare il valore dei beni da scambiare, non ancora si può parlare di moneta ma solo di baratto. Questo perché, sebbene già in quel momento fosse necessario l’accordo tra gli agenti commerciali sul tipo di metallo e sulla quantità necessaria agli scambi – accordo generalmente garantito da patti sacralmente consacrati all’ombra dei templi che costituivano, per l’epoca, l’elemento “fiduciario” ossia “indotto” sussistente anche in quella fase primordiale – di moneta vera e propria può parlarsi solo con l’intervento dell’Autorità politica, che era in antico anche Autorità religiosa, attraverso la coniazione della moneta aurea o argentea o ramata.
E’ stata la coniazione a trasformare il semplice pezzo di oro, o argento o rame, pesato sui banchi in moneta ovvero è stata la coniazione, anche per impedire truffe e per imporre un ordine monetario, ad attribuire all’oro, o all’argento o al rame, il “potere d’acquisto” indipendentemente dal suo valore intrinseco di merce, benché questa indipendenza non si palesò immediatamente alla coscienza sociale. Era moneta, ossia potere d’acquisto obbligatorio per tutti, solo il pezzo di oro, o argento o rame, fuso nella quantità stabilita dal sovrano e che recava la sua immagine.
Quando, più tardi, venne introdotta la carta moneta questo avvenne, in occidente e nel medioevo, ad opera di mercanti e cambiavalute (i precursori dei moderni banchieri) che la introdussero quale certificato di deposito o cambiale garantita dalla moneta aurea e coniata ad essa sottostante. In tal modo la carta moneta assunse presso il pubblico un carattere fiduciario di riserva di potere d’acquisto legale in quanto garantita dalla moneta metallica coniata. Così appunto avvenne. Ma poteva anche non accadere laddove il pubblico, o parte di esso, avesse rifiutato la carta moneta preferendo, per maggior fiducia, la moneta aurea coniata.
Successivamente, proprio allo scopo di rafforzarne la fiducia presso il pubblico, anche la moneta cartacea finì per entrare nell’area del conio statuale fino ad assumere potere d’acquisto obbligatorio per legge. Questo accadde ad iniziare dalla fondazione nel 1694 della Banca d’Inghilterra, ossia della prima Banca Nazionale antesignana della moderne Banche Centrali, che ottenne dal re l’appalto in monopolio dell’emissione di carta moneta, garantita dalle monete auree o dall’oro presso di essa depositato, per poi prestare, a scopo di profitto speculativo, detta moneta cartacea sia allo Stato che al pubblico, mosso a fiducia dall’imprimatur regale, ad un tasso di interesse pari all’8% ma stampandone in quantità più che proporzionale ai depositi.
Quando Giacinto Auriti parlava di “valore indotto” si limitava a tradurre in termini giuridici, gius-privatisti per la precisione essendo egli un civilista, questo percorso storico in verità basato più sulla consuetudine, appunto indotta, all’accettazione di moneta cartacea di origine bancaria, nella convinzione della garanzia costituita dalla moneta aurea legale ad essa sotto stante, che non sulla “convenzione” che era il termine, giuridico, preferito dal professore guardiese.
Proprio perché il potere d’acquisto della carta moneta si fonda su detta accettazione fiduciaria essa, la moneta cartacea, sostiene Auriti, deve essere accreditata, e non addebitata, ai cittadini ed allo Stato all’atto dell’emissione, ossia all’atto della creazione di moneta dal nulla, da parte della Banca Centrale e, aggiungiamo noi, da parte della banche ordinarie nel caso della moneta bancaria creata ex nihilo anch’essa.
Auriti cerca di spiegare il fenomeno dell’accettazione fiduciaria della carta moneta, che è stato il risultato di un processo storico piuttosto che di una “convenzione tacita”, con circonvoluzioni filosofiche del tipo “la moneta in quanto misura del valore è anche valore della misura” le quali intendono esprimere una concezione dell’utilità, autorefenziale al soggetto, quale rapporto tra fasi nel tempo, tra la fase strumentale e la fase edonista: uno strumento acquista utilità per chi ne prevede l’uso, una penna è utile solo per chi prevede di scrivere, sicché la moneta, cartacea o aurea, è utile solo perché prevedo lo scambio dei beni con essa attuabile.
Tuttavia questo elemento soggettivista in Auriti evita le aporie dell’idealismo, ossia l’indistinzione tra io e non-io, tra soggetto ed oggetto, laddove l’approccio soggettivo al giudizio di valore è riconnesso, nella sua teoria monetaria, al realismo filosofico, accreditato con certezza dalla tradizione teologica cattolica, per il quale l’ordine della realtà è dato, donato, e non costruito dal soggetto, perché l’io trova l’ordine intorno a sé ed indipendentemente da sé in quanto donato da un Amore Superiore. In tal modo in Auriti, pur fondandosi il giudizio di valore su un approccio alquanto soggettivista, viene mantenuta la distinzione ontologica tra soggetto ed oggetto, sul piano orizzontale, e quella tra Creatore e creatura, sull’Asse verticale.
Alcuni critici hanno contestato Auriti mettendo in rilievo che il potere d’acquisto della moneta cartacea non è dato tanto dall’accettazione fiduciaria di essa da parte dei cittadini, o un tempo dei sudditi, quanto, appunto, dal fatto che lo Stato impone ex lege, mediante il conio, il potere d’acquisto. Esistono – affermano detti critici – precise norme giuridiche le quali stabiliscono che i pagamenti debbano avvenire in moneta cartacea a corso legale, sicché se qualcuno non accettasse detta moneta nulla potrebbe pretendere, in sede giudiziaria, dal debitore il quale, a fronte del suo rifiuto di creditore, abbia deposto la somma oggetto del dovuto presso una banca o un notaio, a disposizione del creditore, liberandosi così dal debito. E’ pertanto, dicono i critici di Auriti, la legge a stabilire l’effetto liberatorio della moneta cartacea a corso legale e non la fiducia in essa riposta dai cittadini, ossia il “valore indotto”.
Altri critici, vicini alla Modern Money Theorie, fanno osservare che la moneta, cartacea o aurea, assume potere d’acquisto, quindi anche corso legale, in quanto è lo Stato a stabilire che le tasse ed i servizi pubblici possono essere pagati solo con la moneta a corso legale, cartacea o aurea, ossia quella imposta dallo Stato medesimo. Pertanto anche laddove i cittadini accettassero orizzontalmente, come mezzo di pagamento, un simbolo monetario diverso da quello ufficiale poi dovrebbero cambiare quel simbolo con quello legale, imposto dallo Stato, per pagare i tributi ed accedere ai servizi pubblici, ossia ogni qual volta essi entrassero in contatto con il Pubblico Potere. In effetti il “valore indotto”, storicamente, come si è visto, si è manifestato come “induzione” dei sudditi da parte del sovrano ad aver fiducia nella cartamoneta emessa dalla Banca, fino ad assumere, nel tempo, il carattere massimo di “induzione obbligatoria” con l’imposizione del corso forzoso per la moneta cartacea di origine bancaria.
Questi critici colgono senza dubbio alcuni aspetti del fenomeno monetario in qualche modo non ben chiaramente evidenziati da Auriti e tuttavia, a ben vedere, tali critiche non vanificano affatto la validità della teoria auritiana.
Auriti da civilista era portato a ragionare in termini di “convenzione” o di “contratto”, avvicinandosi sotto certi profili al contrattualismo sociale (del resto egli era di giovanile, benché poi superata, formazione culturale liberale), e dimenticava che nel “contratto sociale”, proprio perché essa impone una sola moneta, quella coniata ed a corso legale, con effetto liberatorio per il pagamento dei tributi e per la risoluzione inter-soggettiva tra cittadini dei rapporti creditizi, l’Autorità politica, lo Stato, entra a pieno titolo. L’Autorità politica della convenzione monetaria diventa, insieme ai cittadini, protagonista principale. Auriti troppo attento all’aspetto orizzontale del patto sociale dimenticava l’aspetto verticale altrettanto importante e cogente.
D’altro canto, però, in una concezione contrattualista, come quella alla quale in qualche modo la tesi auritiana si avvicina, la stessa legge, ad iniziare dalla costituzione, altro non è che l’espressione per eccellenza del contratto sociale. Sicché la legge che impone il corso legale del simbolo monetario, cartaceo o aureo, che quindi mediante il conio induce il potere d’acquisto nel simbolo, è essa stessa la convenzione sociale monetaria alla quale faceva riferimento Auriti. La legge, in altri termini, è essa stessa la convenzione tra i cittadini che attribuisce “valore” al simbolo monetario, cartaceo o aureo.
Qui, dal punto di vista cattolico che era quello che rivendicava Auriti per sé, si apre un delicato problema filosofico.
Non c’è alcun dubbio sulla adesione di Auriti alla fede cattolica. Egli, ad esempio, indicava nella proprietà popolare della moneta l’unico modo per realizzare concretamente la Dottrina Sociale Cattolica fondata sulla “proprietà per tutti” (Leone XIII) ossia sulla redistribuzione sociale, non sulla abolizione, della proprietà. Egli, infatti, spiegava che il “valore indotto” sotto il profilo giuridico si palesa come un “bene immateriale” ed, in quanto tale, oggetto del diritto di proprietà. Mentre la dottrina liberale, elaborata per i ricchi, concede a tutti formalmente la tutela e la garanzia del diritto di proprietà, ma non anche sostanzialmente la proprietà a tutti, e mentre la dottrina marxista, nel tentativo di garantire a tutti il godimento della proprietà finisce per negarne alla persona umana il diritto formale attribuendo ogni godimento di fatto delle proprietà nazionali alla nomenclatura del Partito Unico, impadronitosi dello Stato, la teoria popolare della moneta, sosteneva Auriti, attribuisce a ciascun cittadino sia il diritto di proprietà sia il contenuto sostanziale di tale diritto, ovvero il bene immateriale, il valore indotto o potere d’acquisto, contenuto nel simbolo monetario, realizzando così il “diritto (a contenuto) sociale” e la connessa redistribuzione dei beni auspicati dal Magistero della Chiesa.
Orbene, il ricorso da parte di Auriti al concetto giuridico di “convenzione monetaria”, come detto, finisce per avvicinarlo al contrattualismo sociale che non è proprio compatibile con l’idea cattolica della comunità politica. La quale nella concezione cattolica non è tale per contratto, come ritenevano Hobbes, Rousseau e Locke, pur ciascuno con le proprie peculiarità filosofiche, ma è tale per natura, come ritenevano invece l’Ipponate e l’Aquinate.
L’uomo per nascita e per status esistenziale appartiene sempre ad una o più comunità, una delle quali è la comunità politica che nella storia ha assunto forme diverse e da ultimo, nella modernità, quello dello Stato nazionale, attualmente in via di superamento post-moderno. L’appartenenza sociale dell’uomo non è mai una sua libera scelta o una sua decisione volontaria e soggettiva. Gli uomini non stipulano alcun fantomatico “contratto sociale” dal quale dipenderebbe ontologicamente la comunità e la stessa Autorità politica. Non è affatto il patto tra liberi ed eguali che da origine alla comunità politica. Essa ha origine per natura ossia per quella legge di natura da Dio infusa nella struttura creaturale dell’umanità.
Si nasce in una famiglia ed in una nazione, dunque si vive in un contesto politico, non per scelta né, come ritengono i contrattualisti, si può scegliere di rinnegare nascita ed origine per stabilire contrattualisticamente un’altra forma di convivenza sociale a proprio beneplacito. Anche le capacità e le doti che Dio dona a ciascuno di noi non sono una nostra scelta sicché persino l’appartenenza professionale, benché spesso imposta anche da altre circostanze sociali, non dipende esclusivamente dalle proprie soggettivistiche scelte ma dalla propria “vocazione” e, nell’attuale condizione post-adamitica, solo chi riesce a realizzarla conosce un approccio gioioso e non penoso al lavoro, a dimostrazione che, appunto, anche i talenti – che non a caso erano una moneta e furono usati nella nota parabola evangelica – sono un dato di natura e non una scelta volontaria. E’ molto importante ricordare questo oggi che le assurde teorie del gender vogliono far credere che persino la sessualità sarebbe una scelta volontaria, culturale, e non un dato di natura, sicché chiunque a proprio piacimento può decidere di essere uomo o donna indipendentemente dalla propria oggettiva sessualità di nascita.
Tuttavia, e con ciò vogliamo recuperare Auriti al suo dichiarato cattolicesimo, benché il fondamento del Politico sia per natura, e non per contratto, l’elemento soggettivo, dunque la volontà umana e quindi l’aspetto contrattuale, ha un suo ruolo anche nel contesto della dottrina cattolica sulla comunità politica purché resti salvo il fondamento di natura del Politico. In altri termini se la comunità politica non nasce per contratto, quel che dalle decisioni umane, quindi mediante forme contrattuali, possono nascere sono le deliberazioni che traducono dalla potenza all’atto il Politico, il quale però rimane, in essenza, un ambito naturale nel più vasto Kosmos molteplice, gerarchicamente disposto dallo Spirituale al materiale passando per lo psichico, della Creazione. La nascita del Regno d’Italia è stata proclamata nel 1871 e quella della forma repubblicana dello Stato italiano nel 1846 per deliberazione umana ma questo non significa che lo Stato, o meglio la Comunità Politica della quale lo Stato è solo la versione moderna, in sé, ontologicamente, abbia fondamento deliberativo, contrattuale, volontarista. La proclamazione del Regno d’Italia e quella della Repubblica Italiana sono stati solo la traduzione, questa sì per decisione umana, dalla potenza all’atto della Comunità Politica quale idea, o ente ideale, ontologicamente sussistente in Dio e riflessa, per natura, nella creazione e nella storia (se poi questa o quella comunità politica, questo o quello Stato, conformano i propri ordinamenti alla legge di natura, riflesso di quella eterna, è altro discorso, ben potendo la protervia umana imporre ordinamenti ad essa contrari). Si può, in proposito, fare il paragone con il matrimonio che è sacramentalmente indipendente dalla volontà umana, perché istituito da Dio, ma che si attua mediante il libero consenso dei nubendi. Così la comunità politica è di natura, quindi voluta da Dio, ma trova storicamente attuazione, nelle sue varie forme, anche per decisione umana.
Tenendo conto di questo, il presunto “contrattualismo” auritiano si rivela invece perfettamente conforme al tradizionale insegnamento cattolico sul Politico, laddove la “convenzione monetaria” venga intesa non quale fondamento soggettivista del fenomeno monetario, che invece dipende dal ruolo naturale attribuito da Dio, nel più vasto Ordine della Creazione, all’Autorità politica, espressione del corpo sociale dei cittadini e di cui la sovranità monetaria è attributo tra i principali, ma quale mero momento attuativo del fondamento naturale del fenomeno monetario nel suo passaggio ontologico dalla potenza all’atto.
Abbiamo detto che è inopportuna ogni diatriba tra scuole monetarie eterodosse, ciascuna delle quali coglie un dato di verità, a fronte dell’egemonia del mainstream classico e neoclassico.
Il mainstream riduce, con nostalgia materialista dell’oro, la moneta ad una merce laddove invece il suo carattere non merceologico è sempre stato un fatto evidente sin dal tempo della coniazione della moneta aurea la quale, prima di essere coniata per atto politico del sovrano, non era neanche moneta ma solo merce da baratto, ossia non possedeva il potere d’acquisto fiduciario (fiducia nell’accettazione del simbolo, in origine metallico, non per il suo valore intrinseco ma per accordo) garantito dall’Autorità politica.
Scollegare le teorie monetarie eterodosse, invece di coglierne le evidenti convergenze, non è mai un buon servizio alla causa della lotta all’egemonia usurocratica.
Auriti, per il quale la moneta era prima di tutto una fattispecie giuridica e solo dopo anche economica, svelando il “valore indotto” come spiegazione, ed altro nome, del “potere d’acquisto”, appartiene a pieno titolo al novero di coloro che rigettano il fondamento materialista dello strumento monetario ed accolgono la dematerializzazione della moneta come un grande passo dell’intelligenza umana il quale al pari di ogni atto dell’umana intelligenza, del tutto libera di accettarsi quale immagine di Dio o di annientarsi prometeicamente nel rifiuto di tale iconicità, può essere benefico o malefico a seconda della disposizione spirituale di apertura o di chiusura del cuore alla Verità rivelata.
La concezione del “valore indotto” quale “bene immateriale”, suscettibile di diritto di proprietà, pone Auriti tra i contestatori della moneta merce, e quindi tra i fautori della necessaria dematerializzazione dello strumento monetario, benché, per un altro verso, continui a sussistere in lui anche una concezione patrimoniale della moneta ma, appunto, non più materialistica.
Ora, per Auriti e per gli altri eterodossi della moneta il problema vero resta quello dell’ancoraggio della moneta, che non ha valore intrinseco, neanche nel caso della moneta aurea, a causa della materia dalla quale è costituita, ad un ordine etico eteronomo che chiama poi inevitabilmente in causa l’ambito del Politico e quello del Santo/Sacro. Ma questo è un discorso che ci porterebbe troppo lontano e che qui lasciamo solo quale accenno.
Auriti definiva la moneta “valore indotto/bene immateriale”, Ezra Pound “certificato di lavoro compiuto garantito dallo Stato”, Augusto Graziani “segno o simbolo di una promessa di pagamento”, Fernando Ritter “pseudo-capitale”, ma tutti avevano, ciascuno a modo suo, intuito il carattere non merceologico della moneta.
Anche la concezione di Gesell, secondo la definizione proposta dall’amico Andrea Cavalleri, per la quale la moneta è “unità di misura della proprietà” o “titolo in bianco di proprietà” appartiene al novero eterodosso della contestazione del carattere di merce della moneta. Perché è evidente che se essa serve ad acquistare i beni della produzione umana, del lavoro umano, sicché ciascuno mediante la moneta si appropria di una quota del lavoro sociale al cui ammontare globale ha contribuito con le sue fatiche da degnamente ricompensare, essa non è una merce, quindi non siamo in presenza di un baratto, ma uno strumento comunitario, un simbolo, al quale quella comunità ha deciso di attribuire, per fiducia e per disposizione normativa, il potere d’acquisto, nel quale ha deciso di indurre “valore indotto” determinato dall’accettazione popolare e dal corso forzoso e legale del simbolo in questione.
L’idea geselliana della moneta quale strumento di redistribuzione sociale dei beni prodotti da una comunità nazionale affonda le sue radici nel socialismo non marxista sulla scia tracciata da Joseph Proudhon con la sua proposta di una banca popolare, che altro poi non era che la riproposizione delle esperienze mutualistiche, caritative e solidaristiche già conosciute dalla Cristianità medioevale con gli antichi monti di pietà.
L’emergere a fine XIX secolo, sia in seno al cattolicesimo tradizionalista intransigente e sociale sia in seno al socialismo a-marxista, del movimento cooperativistico fondato sulla casse mutue e le banche popolari fu l’espressione di una sensibilità social-creditista, che più tardi il maggiore C. H. Douglas tentò, senza particolare successo, di strutturare scientificamente e politicamente. Sensibilità alla quale si ispirò anche Silvio Gesell quando, da ministro della effimera repubblica bavarese, introdusse la sua moneta prescrittibile, poi ripresa negli anni ’30, con notevoli pubblici vantaggi, dal sindaco del paesino austriaco di Wörgl.
Ecco perché mettere in opposizione Giacinto Auriti e Silvio Gesell, pur con le differenze tra essi riscontrabili che tuttavia non ne fanno dei nemici, non ha molto senso. Anche considerando che tra i due c’è Ezra Pound quale garante di una continuità di pensiero lungo una linea la quale non inizia con Gesell e non finisce con Auriti perché si tratta della atavica, primordiale, riflessione umana sul fenomeno monetario e le sue implicazioni etiche di giustizia.
Luigi Copertino